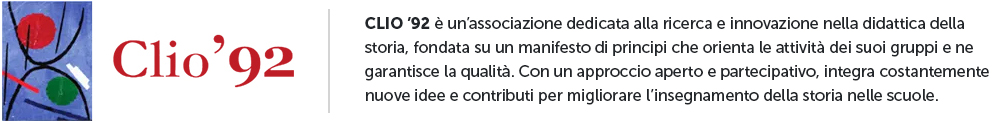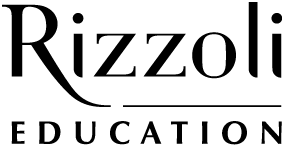La corretta concettualizzazione da parte degli insegnanti di questa triade (ambiente, territorio, paesaggio) è una condizione indispensabile per impostare processi d’insegnamento adeguati a promuovere apprendimenti significativi in campo storico e non solo.
La loro trattazione è raccomandata nei testi delle indicazioni per il curricolo. Ho voluto esplorare quante volte ricorrono i termini “ambiente”, “territorio”, “paesaggio” nel testo delle Indicazioni per il curricolo del 2012 e nella bozza delle Nuove Indicazioni del 2025. I risultati sono questi: le occorrenze per “ambiente” nel testo del 2012 sono 92; nelle Nuove Indicazioni sono 194. “Territorio” ricorre 47 volte nel testo 2012 contro le 102 volte nelle Nuove Indicazioni. Infine, per “paesaggio” nel testo 2012 le occorrenze sono 18; invece, nelle Nuove Indicazioni sono 64. Tenete conto che le pagine delle Indicazioni 2012 sono 68, mentre quelle del 2025 sono il doppio, escluse quelle dedicate alle appendici.
Le discipline che propongono obiettivi riguardanti tali concetti sono molteplici. Purtroppo, la distinzione tra i concetti non è sempre tenuta in considerazione ed essi appaiono come sinonimi in opere di storici, di geografi, in libri di testo e nelle Indicazioni. Ecco due esempi di confusione di concetti. Le Indicazioni del 2012 citano a sproposito il “paesaggio” già all’inizio della premessa delle Indicazioni di storia: “Il senso dell’insegnamento della storia. Nel nostro Paese la storia si manifesta alle nuove generazioni […] nei tanti segni conservati nel paesaggio, nelle migliaia di siti archeologici […]”.
Nella introduzione alla geografia i due termini “territorio” e “paesaggio” si susseguono come sinonimi:
“La conoscenza e la valorizzazione del patrimonio culturale ereditato dal passato, con i suoi segni leggibili sul territorio, si affianca allo studio del paesaggio, contenitore di tutte le memorie materiali e immateriali anche nella loro proiezione futura.”
Tra gli obiettivi ce ne sono due sotto il titolo “Paesaggio: – conoscere il territorio circostante attraverso l’approccio percettivo e la osservazione diretta; – individuare descrivere gli elementi fisici e antropici che caratterizzano i paesaggi dell’ambiente di vita della propria regione. L’obiettivo seguente è intitolato “Regione e sistema territoriale: – comprendere che il territorio è uno spazio organizzato e modificato dalle attività umane.”
Analogo uso sinonimico si trova nella bozza delle Nuove Indicazioni. In storia l’esempio di modulo interdisciplinare di apprendimento, destinato ad una quinta classe di scuola primaria, raccomanda di fare “esplorare il passato e il presente del territorio”. E di seguito si alternano territorio e paesaggio:
“Gli studenti esploreranno il loro territorio per comprenderne la storia, l’evoluzione e il valore culturale. Attraverso il confronto con fonti storiche, mappe e testimonianze, impareranno a leggere il paesaggio urbano e a collegarlo agli eventi del passato.
- Come è cambiato il mio territorio nel tempo?
- Quali eventi storici hanno lasciato traccia nel paesaggio urbano?”
In geografia sono affiancati “Paesaggio e territorio: – Riconoscere valori e criticità del territorio, sviluppando consapevolezza e responsabilità ambientale. Analizzare paesaggi e territori lontani, considerando diversità, valore estetico e problematiche globali come cambiamento climatico, migrazioni e impatto umano.
In principio c’è l’ambiente naturale
Nella bozza delle NI si elencano “gli elementi dell’ambiente: suolo, acqua, aria, piante, animali, microrganismi”. È la qualità di tali elementi che determina la sostenibilità ambientale. Immaginate la Terra prima della formazione dell’umanità sapiens. Essa era cosparsa solo da ambienti naturali.
Poi ambienti naturali vengono trasformati in territori
Ora immaginate gruppi umani che modificano un ambiente costruendo e depositando manufatti e alterando alcuni degli elementi caratteristici dell’ambiente: ad esempio, abbattimento di alberi per costruire case e creare prati per l’allevamento o campi coltivati. Il risultato di tali interventi è la trasformazione di un ’”ambiente naturale” in un “territorio”. Il processo di trasformazione lo chiamiamo “territorializzazione”.
“Ambiente antropizzato” Ma il concetto di “ambiente” è utile anche per comprendere come le attività umane e i manufatti incidono su alcuni o su tutti gli elementi ambientali e producono un ambiente antropizzato. Pensate, ad es., come i fertilizzanti peggiorano la qualità del territorio coltivato, rendendolo un ambiente malsano o come l’aria di un ambiente urbano può risultare inquinata.
E come si distingue il concetto di “paesaggio”?
Il paesaggio è una porzione di territorio come appare abbracciata dallo sguardo di un osservatore, da un determinato punto di visuale; è tutto ciò che si vede quando si guarda un’area del territorio o una porzione di ambiente naturale.
Pensate alle fotografie che riprendono parti di ambienti naturali o di territori. Esse danno la possibilità all’osservatore attento di percepire la qualità estetica, le interrelazioni tra fattori naturali e/o umani, le tracce delle attività umane.
Ma le immagini non danno la possibilità di comprendere quali siano le caratteristiche ambientali delle porzioni di superficie terrestre rappresentate. Il paesaggio potrebbe apparirci attraente, ma la qualità del suolo, dell’acqua, dell’aria potrebbe risultare preoccupante a causa dei principali agenti inquinanti e pericolosi per la salute.
Possiamo attribuire un forte potenziale formativo alle conoscenze che permettono di sviluppare – in modo appropriato – questi concetti fondanti della storia, della geografia, delle scienze. Infatti, gli alunni potranno applicarli alla comprensione di fenomeni attuali e delle questioni relative ai rapporti tra clima, ambiente, territorio e tecnologia.