AI e storia
I chatbot AI conversazionali grazie alla capacità di comprendere e rielaborare il linguaggio umano, e di generare nuovi contenuti su richiesta dell’utente, rappresentano una nuova tipologia di “collaboratori” o “tutor” digitali: possono essere coinvolti attivamente nella didattica della storia, offrendo per chi studia opportunità inedite di esplorazione, simulazione e riflessione critica sul passato.
La storia rappresenta infatti un terreno particolarmente fertile per l’implementazione dell’intelligenza artificiale nella didattica, per diverse ragioni, tra la quali si possono citare:
- Multidimensionalità: eventi, personaggi, contesti in epoche diverse offrono infinite possibilità di interrogazione e interazione, coinvolgendo i chatbot AI.
- Complessità interpretativa: le diverse possibili letture degli eventi storici permettono di esercitare il pensiero critico, valutando le proposte dell’AI.
- Struttura relazionale: i nessi causali e le interconnessioni tra gli eventi storici sono un campo ideale per testare la capacità dei sistemi AI di elaborare reti complesse di eventi e informazioni.
Per un uso consapevole dell’AI
L’interazione con i chatbot AI permette di impostare attività didattiche coinvolgenti e partecipative, in grado di attivare competenze disciplinari e life skills come problem solving, collaborazione, pensiero creativo, empatia, consapevolezza di sé e, soprattutto, pensiero critico. Quest’ultimo deve diventare un punto di riferimento sia per chi insegna, sia per chi apprende, per stabilire un’interazione consapevole, sicura e responsabile con i software basati sull’intelligenza artificiale: nonostante abbiano sempre la “risposta pronta”, i chatbot AI non sono infatti “oracoli” infallibili, poiché possono generare contenuti con errori, inesattezze, informazioni completamente inventate e pregiudizi etnici, culturali e di genere. I contenuti generati vanno quindi sempre analizzati criticamente e verificati.
Dialogare con l’AI in ambito storico
Per comunicare con i chatbot AI si utilizzano i prompt, cioè istruzioni in formato scritto o vocale, con le quali avviamo e gestiamo l’interazione con il chatbot. La progettazione efficace dei prompt è una nuova e importante competenza digitale, imprescindibile per ottenere risposte pertinenti e utili all’obiettivo didattico e per limitare il più possibile la generazione di risposte errate, inappropriate e/o fuori contesto, da parte dei chatbot. Tanto più, nell’orizzonte dell’insegnamento storico dove precisione contestuale e accuratezza sono essenziali.
Proprio per questo, nelle attività con l’AI proposte all’interno del manuale (di cui daremo a seguire due esempi svolti) abbiamo deciso di dare particolare rilievo all’impostazione dei prompt, con suggerimenti pratici, modelli ed estratti di interazioni con i chatbot.
Ecco alcune strategie utili da attuare nei dialoghi con i chatbot AI, con riferimento specifico alla didattica della storia:
- Contestualizzazione storica precisa: definire con chiarezza periodo storico, area geografica e contesto culturale.
- Assegnazione di un ruolo specifico: indicare all’AI il suo specifico ruolo nell’attività, la prospettiva interpretativa che deve fare propria o la figura storica di cui deve assumere il punto di vista.
- Specificazione del formato della risposta: chiarire l’impostazione desiderata per i contenuti generati, per esempio un dialogo simulato, un’analisi comparativa, un documento d’epoca verosimile o uno scenario controfattuale.
- Indicazione del livello di complessità: adattare il linguaggio e il livello di approfondimento storico all’età e alle competenze degli studenti.
- Delimitazione contenutistica: precisare quali argomenti, processi ed eventi includere e quali invece escludere.
L’AI nel tuo manuale di storia
Il percorso didattico con l’intelligenza artificiale proposto in Visione storica è stato progettato per accompagnare, sia insegnanti sia studenti e studentesse, in un’implementazione graduale e consapevole dell’AI nello studio della storia. Abbiamo per questo sviluppato una struttura ricorrente nei tre volumi, con quattro tipologie principali di attività nei laboratori di fine unità (vedi sotto), che integrano e approfondiscono le esercitazioni AI (più contenute) presenti nei singoli capitoli. Con variazioni e complessità crescenti man mano che si avanza nel percorso.
Per rendere più concreta l’esperienza di apprendimento, nelle attività laboratoriali viene proposto un esempio di dialogo avviato con un chatbot AI, utile per comprendere i risultati ottenibili con prompt ben formulati e anche l’importanza dell’iterazione, ossia il processo di affinamento progressivo del dialogo con l’AI per ottenere risposte sempre più precise e pertinenti.
- INTERVISTA IMPOSSIBILE
Il chatbot AI assume il ruolo di un celebre personaggio storico e risponde alle domande preparate dagli studenti.
Life Skills: pensiero critico, relazioni efficaci, empatia
- DEBATE STORICO
Studentesse e studenti avviano un dibattito su una questione storica di particolare rilevanza. Il chatbot AI partecipa con un ruolo specifico e che può variare: controparte, giudice, generatori di argomenti di discussione ecc.
Life Skills: pensiero critico, capacità decisionale, relazioni efficaci
- TESTIMONIANZA DAL PASSATO
Studentesse e studenti immaginano di essere personaggi storici (celebri ma anche persone comuni) e scrivono un diario, una testimonianza, una lettera ecc. Il chatbot AI aiuta gli studenti a costruire descrizioni realistiche, fornendo suggerimenti e feedback sugli elaborati.
Life Skills: Consapevolezza di sé, empatia, pensiero creativo
- PROBLEM SOLVING STORICO
Alle studentesse e studenti viene presentato un evento chiave, un dilemma storico o una sfida del passato, chiedendo di analizzare la situazione e proporre soluzioni/prendere decisioni, valutando diverse opzioni e possibili conseguenze. Il chatbot AI viene coinvolto per ottenere suggerimenti, ma anche per verificare la plausibilità storica e le possibili conseguenze degli scenari proposti.
Life Skills: problem solving, pensiero critico, capacità decisionale, gestione dello stress
Per approfondire
Proposta di laboratori AI dal manuale Visione storica di S. Manca, G. Manzella e S. Variara, La Nuova Italia 2025.
- PROBLEM SOLVING STORICO Galileo a processo
- INTERVISTA IMPOSSIBILE Napoleone… si racconta
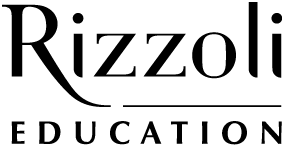

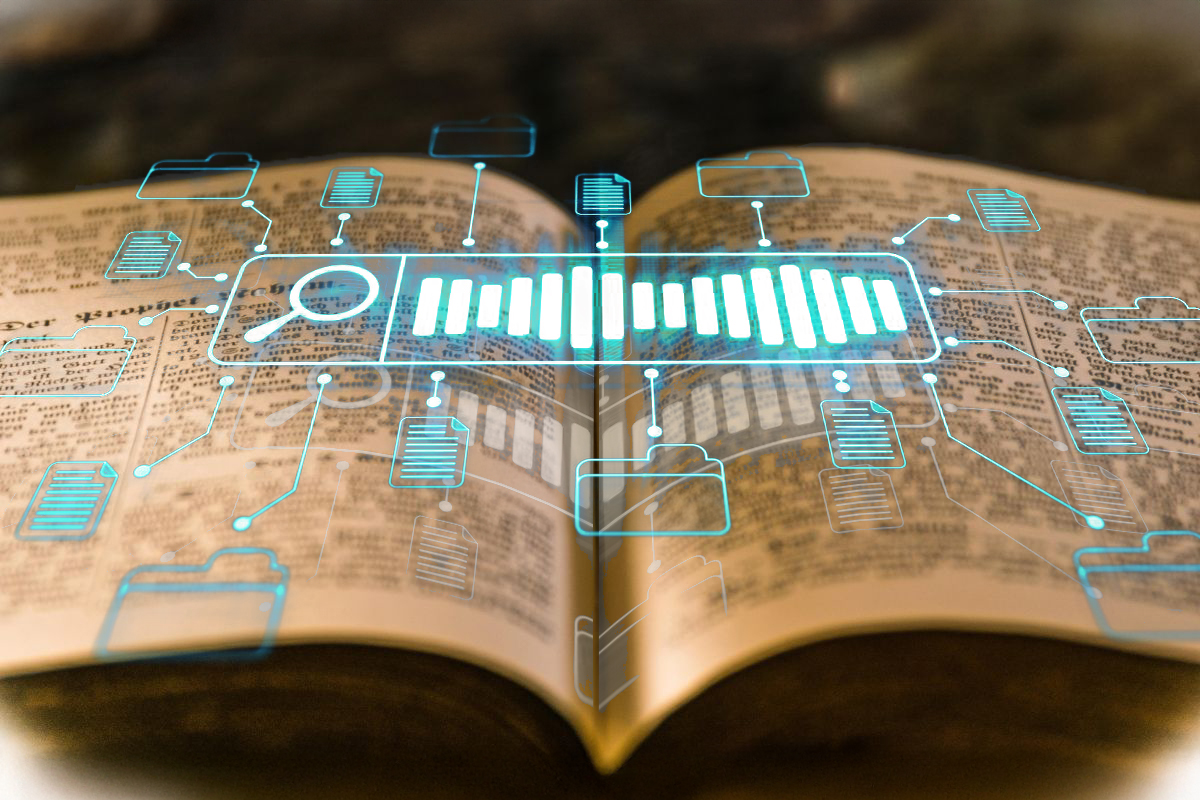



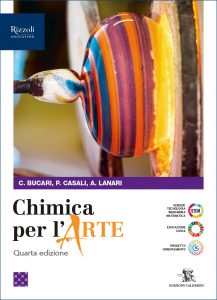 Scopri di più nella Novità 2025
Scopri di più nella Novità 2025 

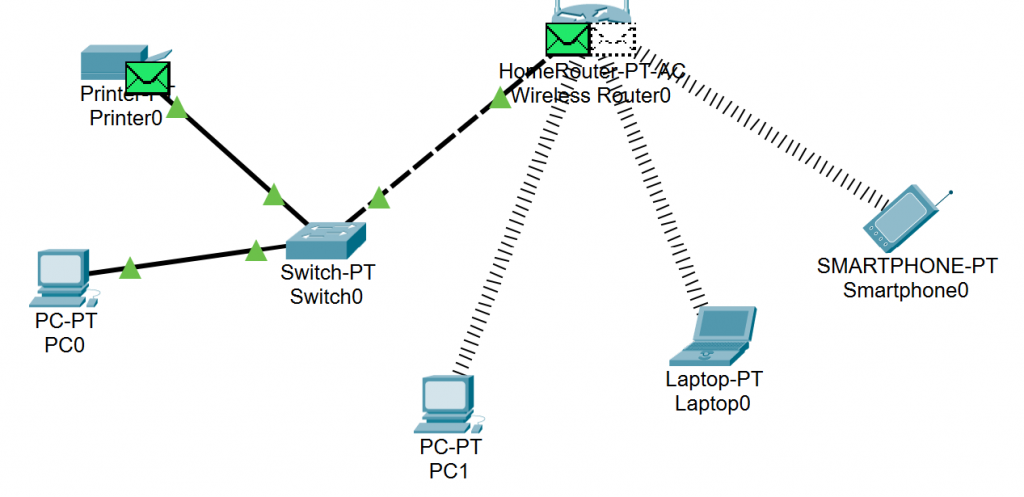

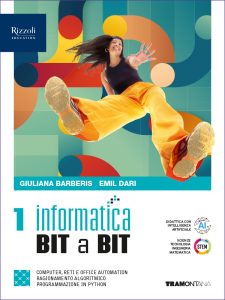


 Warsan Shire is a Somali-British poet, writer, and activist, known for her powerful and evocative works that explore themes of identity, migration and displacement. She was born in Kenya to Somali parents in 1988 and moved to the United Kingdom as a young child. She was awarded the inaugural
Warsan Shire is a Somali-British poet, writer, and activist, known for her powerful and evocative works that explore themes of identity, migration and displacement. She was born in Kenya to Somali parents in 1988 and moved to the United Kingdom as a young child. She was awarded the inaugural 


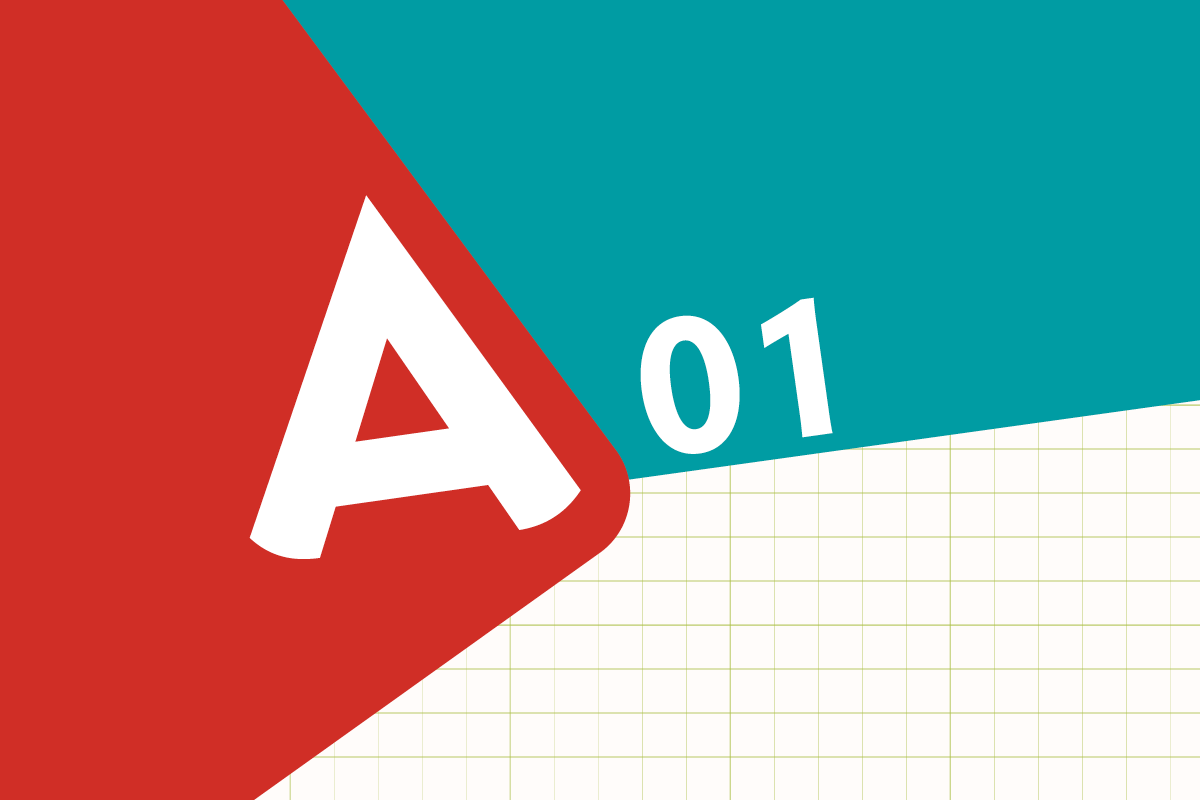

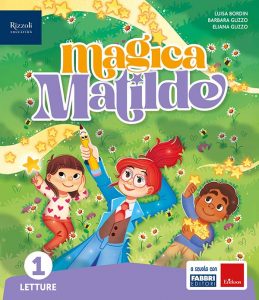 Scopri il corso
Scopri il corso